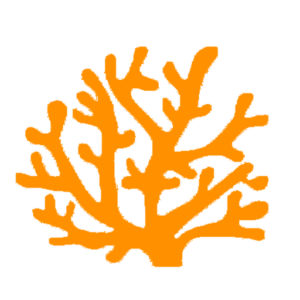Sono nato a Brindisi nell’ottobre del 1975, da genitori entrambi cestisti. Perciò suppongo di aver toccato il mio primo pallone da basket entro la fine di quello stesso anno.
Un ricordo della mia infanzia: mio nonno che sistema ventuno formine colorate su una specie di tavoletta. La capovolge, e contrariamente a tutto quello che ho capito del mondo, le formine non cadono per terra. Alla fine il nonno mi spiega che quella è una lavagna magnetica e che le formine sono le lettere dell’alfabeto. Mi dice che posso giocarci, se voglio.
Nel 1991 sono al terzo anno del liceo classico, e dato che gli allenamenti di basket mi prendono tutto il pomeriggio, per studiare mi sveglio all’alba. Sto per mollare – o la scuola o il basket, ancora non ho deciso – quando mi capita per le mani una versione tratta da Plutarco. I Tebani, c’è scritto, cacciarono gli invasori Spartani sul far della sera, dopo aver trascorso la mattina a sudare in palestra e il pomeriggio a dirimere spinose controversie filosofiche. Questi Tebani, penso. Allenamento e studio nella stessa giornata. E gli è avanzato pure il tempo per la rivoluzione.
Nel 1999, quando alla laurea in lettere mi mancano pochi esami, la cartilagine del mio ginocchio sinistro va in mille pezzi in seguito a uno scontro di gioco. Dopo quattro interventi chirurgici sono costretto ad abbandonare il basket. Alla discussione della tesi ci vado in stampelle.
Nel 2002, incerto tra la carriera universitaria a Milano e la scuola di preparazione all’insegnamento (SISS) a Brindisi, mi massaggio il ginocchio ancora gonfio e prendo una decisione: andrò a Torino per frequentare la Scuola Holden.
Trascorro su quei banchi due anni meravigliosi, nonostante che la pallacanestro mi manchi da morire. Infatti, durante uno dei primi laboratori, scrivo un racconto breve sulla nostalgia per il ball handling, l’esercizio di destrezza con cui di solito iniziano gli allenamenti di basket.
Nel 2004 tengo il mio primo corso alla Holden, dove tuttora insegno – specialmente in Academy, la triennale universitaria.
Nello stesso anno inizio a collaborare con diverse compagnie teatrali, in particolare con l’Accademia dei Folli, che da qui in avanti mi commissionerà testi sui più svariati argomenti, dalle lotte della Resistenza all’invenzione del grissino. Tra drammaturgie vere e proprie, monologhi, reading, recital, lezioni teatrali, visite guidate in forma narrativa e spettacoli itineranti, ho scritto circa un centinaio di copioni.
Sempre in quel periodo lavoro in radio come autore e regista (Radio2 Rai e Radio Svizzera Italiana), anche qui spaziando dal curling di Torino 2006 all’assedio di Leningrado del 1941.
Nel 2007 esce il mio primo romanzo, che ha come argomento il basket e come titolo un mezzo verso di Virgilio: Tre volte invano, Instar Libri, selezione Premio Strega. L’ultimo capitolo è il racconto sul ball handling che avevo scritto alla Holden.
Nel 2010, sempre con Instar, pubblico Alborán, ambientato nel mondo della radio e dedicato a mio nonno, quello della lavagna magnetica.
Nel 2011 collaboro con l’ex arbitro internazionale Roberto Rosetti alla stesura della sua autobiografia: Nessuno parla dell’arbitro, Add editore.
Le vittorie imperfette è il mio terzo libro, il primo con Feltrinelli, apparso nel 2016. Vi si raccontano tre secondi delle Olimpiadi di Monaco ’72.
Quest’ora sommersa, sempre Feltrinelli, dura un po’ di più: sessanta minuti, come dice il titolo, il tempo dell’ultima immersione subacquea di Leni Riefenstahl, la regista di Hitler.
Cos’altro?
Una volta ho segnato 47 punti contro una squadra di Napoli, la Partenope, il nome di una ninfa. Ci ripenso ogni tanto, nei momenti di sconforto. Ho fatto 47 punti contro la Partenope Napoli.
Ogni anno, alle 23.57 in punto della vigilia di Natale, io dovevo fare pipì. A dire il vero lo stimolo non veniva a me, ma a mia zia; mentre eravamo a tavola io ci provavo a puntare lo sguardo dove lei non potesse intercettarmelo – sui resti sconnessi del dolce, sulle bottiglie vuote, persino sul centrino di pizzo rosso che non potevo soffrire –, ma la zia mi fissava in un modo che alla fine ero costretto a ricambiare. E allora prendeva quella sua aria di chi la sa lunga e diceva: “Scommetto che ti scappa.”
A parte che no, non mi scappava: ma poteva esserci un momento più inopportuno di quello? Quando, di lì a pochissimi minuti, nell’altra stanza sarebbe arrivato…
Siccome però passavo per essere – ed ero – un bambino obbediente, la seguivo in bagno senza tante storie e, sempre per lo stesso motivo, la pipì la facevo davvero. Il fenomeno per cui era mia zia ad avvertire il bisogno ma ero io a espletarlo non mi sembrava strano, o almeno non più strano del fatto che tutte le volte, mentre lei mi tirava su la cerniera dei pantaloni – proprio durante quella delicatissima operazione –, dall’altra stanza si sentivano delle urla eccitate. Ecco, era successo di nuovo: mi ero perso il Suo arrivo per fare una pipì che, tecnicamente, scappava a mia zia.
Erano le sette di sera del Natale 1980 quando entrai nella sua stanza; volevo chiederle se per una volta lo stimolo poteva venirle un po’ prima, diciamo verso le 23.40. O magari un po’ dopo mezzanotte. Insomma, non proprio mentre Lui…
Quello che vidi mi ricacciò le parole dentro la gola: con un piede per terra e un altro poggiato sul letto, mia zia si stava tirando su i collant, srotolandoli piano sulle gambe bianche, in un modo che mi fece venire in mente certe ore del pomeriggio in cui la linea scura dell’ombra avanza sul terreno che era stato della luce. L’ombra foderava il polpaccio, il ginocchio e si allungava lentamente sulla coscia, finché una notte nera ricoprì la tortuosa estensione delle sue gambe, e a me sembrò di non aver mai assistito a niente di più bello, mia zia che si infilava addosso l’ombra.
Quella notte, alle 23.57, lei catturò i miei occhi più facilmente del solito. La seguii in bagno, e poco prima che mi abbassasse i pantaloni le chiesi se mi lasciava fare una cosa. Non mi domandò che cosa, disse solo di sì. Le sollevai la gonna con una mano e posai l’altra sulla sua coscia scurita dalle calze, e d’un tratto il cuore prese un’accelerata che non mi aspettavo, mi sembrò persino di sentirlo che batteva sempre più veloce, sempre più forte, talmente forte da coprire le urla eccitate che venivano dall’altra stanza ormai chissà da quanto.
La zia disse che forse adesso era il caso di andare, e io feci di sì con la testa, ma con il resto del corpo non mi mossi.
“Non sei felice? Lui è arrivato…”
Io avevo ancora la mano posata sul nero della sua coscia, il cuore che non la smetteva. “Mai stato così felice,” dissi.
Laeta boum passim campis armenta videmus.
Ne è valsa la pena anche soltanto per sentire il suono di questo verso. Andare al classico, dico.
Ricordo bene il giorno in cui la professoressa Vergine lo scrisse alla lavagna. Poi ce lo lesse, accentando le parole in un modo che mi parve al tempo stesso assurdo e meraviglioso: laèta boùm passìm (pausa) campìs armènta vidèmus.
Ci disse che quello era un esametro – un esametro dattilico, per la precisione. Ci spiegò cosa fosse e perché lo avesse letto in quel modo. Divise le parole in sillabe e snocciolò quella che a me parve una misteriosa sequenza da alfabeto Morse: lunga, breve, breve; lunga, lunga; lunga, breve, breve…
Disegnò su vocali e dittonghi trattini e semicerchi. Ci spiegò cosa fosse un dattilo e cosa uno spondeo. Disse che la pausa che aveva osservato a metà verso si chiamava cesura. L’ultima sillaba di un esametro poteva essere uno spondeo così come un trocheo. Rilesse ancora: laèta boùm passìm… campìs armènta vidèmus.
Probabilmente tradusse anche, ma per una volta non era quello il punto. In fondo si trattava solo di mucche sparse qua e là per i campi. Insomma, non è per questo verso che Virgilio è diventato famoso.
Il suono, ecco qual era il punto. Il modo in cui le parole si susseguivano formando una melodia perfetta, una musica che andava ben al di là del significato letterale. E poi quei nomi – esametro, dattilo, spondeo – altrettanto belli quanto le sequenze ritmiche che dovevano definire.
Il trocheo finale.
Lo so che può sembrare strano, ma a quattordici anni – quanti ne avevo allora, in quinta ginnasio – il trocheo mi risultò subito simpatico. Huc ubi delati portus intravimus, ecce. Se ne stava lì, il trocheo, sempre in fondo al verso, differente da tutti i piedi che lo avevano preceduto. Era l’ultimo a essere scritto sulla lavagna, e il primo a essere cancellato dalla professoressa Vergine.
Vorrei ringraziarla di cuore per quel giorno, e per tutti quelli trascorsi insieme a scuola. Vorrei dirle che le sono riconoscente per avermi svelato, tra le altre cose, la musica nascosta delle parole. E vorrei dirle infine che ancora oggi, nei momenti di sconforto, o quando sono incline alla malinconia, o quando ho bisogno di ricordarmi perché faccio il mestiere che faccio, c’è una frase che mi torna alla mente e che a volte ripeto perfino ad alta voce – laèta boùm passìm… campìs armènta vidèmus –, e pazienza se sono da solo in mezzo alla strada, a Torino, e non c’è una mucca nel raggio di venti chilometri.
Tempo fa, nel bel mezzo della stesura di quello che speravo diventasse il mio primo romanzo, stavo provando a raccontare cosa mi succedeva sul campo di basket quando dentro di me scattava una certa molla, magari dopo essermi inventato un canestro bizzarro. Non mi piacevano né trance agonistica, né invasamento, né stato di grazia. Era qualcosa di più: il fatto è che io, in quei momenti, diventavo… cosa? Ero lì che cercavo la parola mancante – il predicativo del soggetto – quando bussano alla porta.
Vado ad aprire, rinuncio per la decima volta a cambiare il gestore del telefono fisso (che non ho, e sono tre mesi che lo ripeto allo stesso tizio) e, quando mi risiedo davanti al computer, trovo scritto: “Io, in quei momenti, diventavo”.
Ma certo.
Diventare nel senso di essere vento, trasformarsi in qualcosa di imprendibile, di invisibile se non per i suoi effetti.
Ho messo il punto e tanti saluti al predicativo del soggetto.
È un bellissimo verbo, oltre che una bellissima cosa in sé. Viene dal latino ex-ordire e letteralmente significa “iniziare a tessere”.
A me è capitato di esordire due volte, il che potrebbe sembrare una contraddizione in termini e invece, come spero di dimostrare, non lo è.
La prima volta è stata a Firenze, il 17 ottobre del 1993 – mi ricordo la data perché il giorno dopo avrei compiuto diciott’anni. Ero il terzo playmaker della squadra di basket della mia città, Brindisi, che all’epoca militava nel campionato di serie B. Il primo playmaker si era infortunato nel corso dell’ultimo allenamento, così per quella trasferta fui convocato io. Il secondo playmaker, che nelle intenzioni del coach avrebbe dovuto giocare tutta la partita, fece quattro falli dopo appena cinque minuti. Il coach – che per inciso era anche mio zio – si voltò sconsolato verso la panchina, mi guardò e disse: “Entra, va’.” Poi aggiunse: “E che Dio ce la mandi buona.” Non esattamente il più grande incoraggiamento della storia.
Mentre mi toglievo la tuta pensavo a come avevo deciso di trascorrere la vigilia della gara. Dal momento che non ero mai stato a Firenze, al mattino mi ero svegliato molto presto ed ero andato agli Uffizi. Poi avevo visitato le Cappelle Medicee. Infine ero salito in cima al campanile di Giotto, rientrando in albergo appena in tempo per la riunione pre-partita. Insomma ero talmente sicuro di non giocare che ne avevo approfittato per fare il turista. E invece adesso ero lì sul cubo del cambio, accidenti a me, e intanto mi chiedevo quanto potessero incidere sulla mia tenuta atletica gli 828 gradini del campanile di Giotto, 414 a salire e 414 a scendere.
Ma sapete, non andò poi così male. Misi in ordine la squadra, chiamai gli schemi d’attacco, segnai due bei canestri in penetrazione e in definitiva feci tutto quello che ci si aspetta da un play-maker, ossia fare gioco, disegnare passaggi, suggerire movimenti. In altre parole: iniziare a tessere, esordire.
La seconda volta è stata nel settembre del 2007. Nel frattempo mi ero rotto la cartilagine del ginocchio in un incidente di gioco e dopo quattro interventi chirurgici la cartilagine stava peggio di prima. Sentivo che una parte significativa della mia vita era finita per sempre – la parte più vitale, la più entusiasmante. Così avevo lasciato la mia squadra, la mia città e mi ero trasferito a Torino per frequentare la Holden. Terminata la scuola avevo scritto un romanzo, e il romanzo era piaciuto a una casa editrice, la Instar Libri. Parlava di un ragazzino che entrava in campo, metteva in ordine i compagni, chiamava gli schemi d’attacco e faceva canestro.
Sarebbe stato un altro esordio, il secondo, quattordici anni e quattro operazioni dopo il primo. La prova che non era finito un bel niente, che anche quando qualcosa di molto prezioso si lacera, si slabbra e si sfilaccia – una cartilagine, per esempio –, c’è sempre un modo di ripararlo, è sempre possibile scrivere, esordire, ricominciare a tessere.
Ho smesso di giocare a basket molto tempo fa per colpa di un incidente al ginocchio. Ma proprio in questi giorni ho ricominciato.
Sto trascorrendo il lockdown a casa di Eleonora, la mia compagna, che per fortuna ha un bel terrazzo. Sul terrazzo ci sono diverse piante, fra cui un basilico. Con il permesso di Eleonora ho tolto il basilico dal suo vaso e l’ho piantato in un altro vaso, quello del peperoncino. Poi, con un paio di forbici da giardiniere, ho tagliato il fondo del vaso dove stava il basilico e infine l’ho legato con una corda a un palo della tettoia. La palla ce l’avevo già, l’avevo comprata qualche giorno prima in un’edicola: è di gomma, ha le dimensioni di una pallina da tennis, ma è arancione, ha gli spicchi proprio come un pallone da basket e soprattutto rimbalza.
E così ogni mattina mi metto la tuta, esco sul terrazzo di Eleonora e gioco a basket con il canestro che ho costruito con le mie mani e che ancora sa di basilico.
In questi giorni le città sono silenziose, perciò si sentono meglio i suoni della natura. Il vento, per esempio. O i versi degli uccelli. Ne passano tanti sopra il terrazzo di Eleonora mentre gioco a basket: passeri, tortore, gazze ladre, merli e anche gabbiani, visto che il mare non è lontano. Mi piace molto tirare a canestro e intanto ascoltare i versi dei gabbiani, perché somigliano al rumore che fanno le scarpe da basket sul parquet.
Ogni volta che riesco a fare canestro, prima di rimettermi a giocare annuso la palla. All’inizio sapeva di gomma, ma pian piano sta prendendo un altro odore, più buono, più naturale.
Io ho sempre desiderato fare canestro, fin da quand’ero piccolo. Ora ho un motivo in più per desiderarlo. Voglio fare tanti di quei canestri che alla fine del lockdown, quando annuserò la palla per l’ultima volta, saprà inequivocabilmente di basilico.